illustrazione di Matteo Sarlo
parole di Matteo Sarlo
In una recente intervista comparsa sul New York Times per il suo quarto romanzo, Innocents and Others, la scrittrice americana Diana Spotta dichiara che tendiamo a pensare alle macchine as abstractions ma in realtà they are actually things. Non astrazioni, cose. Ma perché dovremmo pensare che uno smartwatch, un laptop o un semplice iPad siano delle astrazioni? Cosa si nasconde nel pensiero apparentemente lineare dell’autrice statunitense? E le cose sono, in effetti, oggetti?
Nerd 1
Ci sono due diversi generi di uomo tecnologico. Al primo posto c’è il soggetto parsimonioso, quello che lavora tanto con il poco che possiede, che desidera una nuova, più potente scheda video per una renderizzazione assai più veloce. Quello che il computer lo assembla da sé e che, al massimo, lo utilizzerà per un vanto istantaneo, costituito da una piccolissima cerchia di amici come lui, una consumazione immediata e veloce di egocentrismo. Un fast egotism ma solo come corollario. Dopodiché si comincerà ad utilizzare il nuovo acquisto. È esattamente chi ancora sogna la merce, come una scheda video o una ventola per il raffreddamento, per il suo utilizzo, chi lo pensa come separata da sé. Ma questo tipo di soggetto è ormai, sempre più, in via di estinzione. O comunque talmente marginale da costituire sì una sfera esistenziale, quella che in fenomenologia si chiamerebbe una micro Sfera della vita, ma non rilevante ai fini di una media, di un campione.
Nerd 2
Poi c’è il secondo genere, più interessante e diffuso e che costituisce invece un caso emblematico. È chi desidera non l’utilizzo della merce, cioè l’oggetto per quel che serve, ma il suo carattere virtuale, il suo valore immaginario, quindi qualcosa che ha a che vedere con la sua apparenza. In altri termini è il caso di chi non compra la scheda video perché poi dovrà avviare una complessa operazione velocemente, e quindi in questo senso per il suo valore d’uso, ma per il suo potenziale che rimarrà inespresso. Si tratta di chi compra l’oggetto tecnologico già sognandone il solo vanto prolungato. In una formula, il Soggetto represso e continuamente deluso dall’Oggetto. Quello che si identifica pienamente con gli imperativi di quel sistema di valori e credenze non scritte che lo psicanalista francese Jacques Lacan ha chiamato grande Altro. È Chi compra per il carattere che potremmo definire volatile della merce, cioè un tipo di qualità invisibile agli occhi che, ben lontana dalla concretezza della nuova potente scheda video del primo soggetto, sola può fondare un’invidia costantemente rinnovantesi da parte del pubblico a cui viene esposto. È il caso non più del ragazzo nerd che mostra agli amici, nel chiuso di una stanza, per una mezz’ora, il nuovo acquisto, ma dell’esposizione, falsamente paradossale, dell’invisibilità della merce h24, attraversando tutte le sfere della vita, dall’ufficio al supermercato, dalle case di amici al ristorante dove avrà un appuntamento amoroso.
La logica delle favole
Ma questo tipo di alternativa, quella cioè tra chi compra per il valore d’uso e chi compra per il valore immaginario, esaurisce davvero il rapporto che l’uomo moderno intrattiene con la merce, vale a dire con il “disumano” quotidiano, con la macchina, con ogni forma di es? E lo scambio sistematico messo in atto nelle favole, per esempio quelle di Esopo, tra uomo e animale non insiste sullo stesso inganno, vale a dire la sostituzione dell’uomo con l’inumano? In effetti sin da piccoli, quando ci viene narrata la storia dei tre porcellini che costruiscono ognuno la propria capanna, non accettiamo forse, inconsapevolmente, il presupposto assurdo di animali parlanti, quindi di animali-uomini, quindi del rovesciamento uomo-animale?
Ma la cosa non finisce qui. Il motore delle favole è stato radicalizzato nella società contemporanea. Gli uomini non si mutano più in quei simpatici porcellini architetti ma in fredde, spersonalizzanti, cose. Un esempio pratico può aiutare. È nota la recente pubblicità del profumo della Lancôme, La vie est belle.
Lo spot: Lancome
La prima inquadratura si posa su un lampadario di cristallo a piena apertura di diaframma, dunque con un risultante effetto di morbido sfocato. Poi la scritta, letta dalla voce stoffosa di Julia Roberts: “In a world full of dictates and conventions, could be another way?”. Segue un’inquadratura sulla città illuminata, e taglio. Dal basso ora la macchina mostra Julia Roberts chiaramente all’interno di un’enorme lussuosa sala. Al centro dell’inquadratura, diretta da Tarsem Singh, per intenderci il regista di Biancaneve- Mirror, mirror dove la diva interpretava l’accidiosa “strega cattiva”, sfila attraverso una festa piena di abiti da sera e cocktail. Sorride a bocca stretta mentre osserva come ogni invitato, parlando e gesticolando, sia inconsapevolmente, per i polsi e per le caviglie, legato da fili argentei. Lo sguardo preoccupato dell’attrice-diva si posa allora sulle sue mani. Anche su di lei stringono i fili di un invisibile burattinaio (il Caso? Il Destino? Dio? La Società Civile?). Ma a differenza di chiunque altro, lei, l’unica ad indossare la sublime fragranza, con un semplice gesto spezza i fili, tramutantesi in turchino pulviscolo fiabesco. A questo punto si dirige su una scalinata che offre un panorama mozzafiato della città. Si gira e sfodera il suo miglior sorriso, disteso e leggero. La voce fuori campo ripete il nome del profumo e del “motto filosofico”, appunto, La vie est belle. Fine.
La lettura ufficiale dello spot, quella offerta dal regista e dal direttore della fotografia Mario Testino, è di una donna che cammina libera dalle restrizioni e dalle convenzioni che il mondo attuale ci impone, richiamandosi all’esegesi della frase di apertura (In a world full of dictates and conventions, could be another way?). In questo senso l’invisibile burattinaio è sicuramente la società, quel sistema di valori e credenze, di “dettami” e “convenzioni”, che regolano ogni soggetto, quel burattinaio che Lacan avrebbe chiamato l’Altro. È una donna libera, slegata dai fili del Simbolico e che, grazie alla fragranza di Iris, Gelsomino e fiori di Arancio, si configura pienamente come “io”, che si ritaglia uno spazio di manovra dall’imperio dell’ordine dei significanti.
Ma le cose stanno davvero così? E se invece lo spot ci dicesse altro? Se invece quel che ci attrae dello spot non fosse la libertà della donna ma la libertà della merce? Quel che ci attrae è Julia Roberts in quanto donna, essere mortale, o è la Cosa Julia Roberts, l’attrice-diva che ha raggiunto l’aspirazione del vero uomo tecnologico, cioè quella di farsi cosa? Nessuno avrebbe certamente qualcosa in contrario nell’affermare che i divi del cinema sono i modelli della nostra società. Ma perchè? Fama, celebrità, ricchezza. Certo. Ma non è tutto qui. Essi compiono qualcosa che non riesce a nessun’altro. Essi realizzano quel che il suddetto Soggetto, quello che costituisce il secondo genere di uomo tecnologico, quello represso e continuamente deluso dall’Oggetto, desidera ardentemente ma non riesce a portare a termine: farsi finalmente, completamente, cosa. E allora il motto che descrive maggiormente il nostro tempo “tecnico” non è forse Menschen sind Sachen (gli uomini sono cose) e non più Menschen sind Tiere (gli uomini sono animali)?
Cosa ne direbbe Günther Anders ?
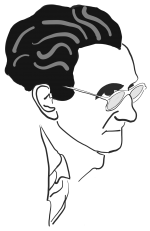
Era l’11 Marzo del 1942 e il filosofo e scrittore nato a Breslavia Günther Anders si trovava con un amico ad una esposizione di tecnologia. Il filosofo racconta che, ad ogni nuovo oggetto esposto, l’amico abbassava gli occhi e ammutoliva. Nascondeva le braccia dietro la schiena come se si vergognasse di quegli arti primitivi, rozzi, antiquati, rispetto ad apparecchi così raffinati, costruiti con precisione e raffinatezza. Manna per un analista del concetto. Tanto che in seguito definì quel particolare tipo di vergogna provata dall’amico «prometeica». Una vergogna cioè generata dal semplice e strutturale fatto di essere nato, invece che essere stato costruito. Di essere evidentemente sempre in divenire, di essere corruttibile, di non essere aggiornabile, riconfigurabile.
E se quindi, a più di cinquant’anni di distanza da quest’episodio, tutto questo circondarsi di tablet, laptop, navigatori, smartphone, non fosse perché, attraverso il loro utilizzo, riusciamo a dominare meglio qualsiasi situazione della nostra vita ma, al contrario, per quanto surreale possa apparire, per un desiderio inconsapevole di essere dominati dalla cosa, di trasformarsi in cosa, vale a dire un archetipico desiderio 2.0 di svincolarci dalla nostra mortalità? E quando si parla di “farsi cosa”, dunque, significa voler essere un oggetto? È la stessa cosa voler essere una cosa e voler essere un oggetto? Un oggetto ha una propria vita? E una cosa? Sarà meglio dirlo subito: le cose, non sono gli oggetti.
Cose ≠ Oggetti
Se, come ha detto Remo Bodei in La vita delle cose, la data di nascita della cosa è arretrabile sino alla latina causa qualcosa che ingloba a tal punto da lottare per essa (non può non venire in mente l’urlo di Mel Gibson in Braveheart poco prima di morire: Libertà!), l’oggetto è un termine più recente, che risale alla scolastica medievale, un calco della parola greca problema e che indica un impedimento, un qualcosa che si frappone e sbarra il cammino. Se un oggetto ci ostacola, una cosa, invece, ci guarda. E, si potrebbe aggiungere, nel duplice significato del termine, ci “riguarda”, cioè ci guarda a sua volta, risponde al nostro sguardo – il comodino vicino al nostro letto, il quadro appeso sopra il cuscino, l’iPad dal suo schermo – e, allo stesso tempo, ci tocca nel profondo. La cosa ha una propria vita e, come tutto il cinema, è legata allo sguardo. Il filosofo franco-algerino Jacques Derrida, uno, a proposito di cinema, con un volto da attore hollywoodiano, ha raccontato di aver provato vergogna quando, un giorno uscendo dalla doccia, ha trovato il suo gatto a fissarlo. E se oggi allora si provasse vergogna non per il gatto ma per lo schermo dell’iPhone (ancora una volta non più per i tre simpatici porcellini parlanti ma per le fredde macchine solo apparentemente spersonalizzanti)? E se, di più, le cose non possedessero solo una propria vita ma anche una loro grammatica sentimentale? Arjun Appadurai, antropologo di Bombay, ne è convinto. Una grammatica sentimentale tutta spostata verso la nostalgia, patimento declinato anche nel suo versante più meramente speculativo, dominante della moderna commercializzazione – in particolare gli Stati Uniti. La sua riflessione investe non tanto la filosofia nel suo senso più puro ma i meccanismi di funzionamento delle moderne società che, attraverso l’utilizzo delle pubblicità, insegnerebbero ai consumatori a sentire la mancanza di cose che non hanno mai perduto, fabbricando una vera e propria “nostalgia immaginata”, implicando consapevolmente quella che Fredric Jameson ha definito come “nostalgia del presente”, locuzione che circoscrive un certo tipo di cinema in cui il presente viene talmente deformato da essere visto da parte dello spettatore come qualcosa che ha già perso. Da American Graffiti a Chinatown, dal Conformista a Brivido Caldo.
Eppure il rapporto dell’uomo con la tecnica è più originario ed evade la dimensione più prettamente commerciale. L’uomo, al contrario dell’animale, si trova nella necessità di costruire sempre il proprio ambiente di sopravvivenza. Fa della tecnica la sua cifra “naturale”, abolendo di fatto qualsiasi punto di immediatezza..
Il ferro e il vetro
Se ancora negli anni cinquanta, nel punto culminate del modernismo, l’oggetto tecnico è qualcosa che s’impone sul paesaggio, e non è un caso se architettonicamente parlando il materiale emblema di quell’epoca fosse il ferro, un oggetto tecnico giganteggiante sulla natura in opposizione ad essa, non è altrettanto un caso se il materiale del post-moderno è il vetro. Non l’Unité d’habitation di Le Corbusier ma il vetro del Bonaventure Hotel di Los Angel. Perché mentre il novum del prodotto tecnico modernista guerreggia contro la città, ne costituisce una caratteristica “singolare”, una dissonanza, sebbene nel sogno del modernismo ci sia l’estensione del suo novum a tutta la città, la lastra riflettente di cui è fatto il prodotto tecnico post-moderno letteralmente ingloba la città, la riflette dentro di sé, la assorbe, la rende, finalmente, immagine.
Nell’epoca del mondo che si fa immagine di se stesso, è allora mutato anche il rapporto che l’uomo intrattiene con la tecnica in un senso quanto più ampio possibile, e con l’oggetto tecnico in un senso più quotidiano, investendo una differente antropologia ma, soprattutto, una rinnovata configurazione estetica.
Lo spot: la Apple cita Walt Whitman
Qualche tempo fa, per pubblicizzare l’uscita del nuovo modello di iPad, la Apple girò uno spot che rende conto esattamente di questa frattura. Per tutto lo spot la voce ripete il monologo del professore di letteratura John Keating, interpretato da Robin Williams in Dead Poet Society, che a sua volta cita il poeta Walt Whitman. Qui è meglio riportarlo nella sua interezza:
Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino: noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana, e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, 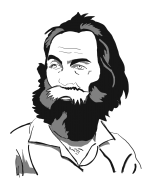 ingegneria sono nobili professioni, necessarie al nostro sostentamento, ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l’amore, sono queste le cose che ci tengono in vita. Citando Walt Whitman, “O me o vita, domande come queste mi perseguitano. Infiniti cortei di infedeli. Città gremite di stolti. Che v’è di nuovo in tutto questo, o me o vita.” Risposta: “Che tu sei qui, che la vita esiste, e l’identità, che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso. Che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso. “Quale sarà il tuo verso?”
ingegneria sono nobili professioni, necessarie al nostro sostentamento, ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l’amore, sono queste le cose che ci tengono in vita. Citando Walt Whitman, “O me o vita, domande come queste mi perseguitano. Infiniti cortei di infedeli. Città gremite di stolti. Che v’è di nuovo in tutto questo, o me o vita.” Risposta: “Che tu sei qui, che la vita esiste, e l’identità, che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso. Che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso. “Quale sarà il tuo verso?”
Gran parte di ciò che è mutato è condensato qui dentro. Non si tratta più di invidiare alla macchina le sue caratteristiche tecniche, immortali, non deteriorabili, sempre aggiornabili e perfettibili, al contrario dell’uomo che lungi dall’aggiornarsi o perfezionarsi va via via peggiorando, deteriorandosi, sino a morire. Non si tratta più di invidiare la tecnica in quanto perfetta in opposizione alla vita: l’oggetto tecnico ne ha ormai assorbito la spiritualità. E mentre l’oggetto modernista voleva imporsi contro la natura, l’oggetto della tecnica nell’epoca del postmodernismo tende a scomparire. L’iPad è un oggetto che tende a nientificarsi. Se potesse, preferirebbe non esserci affatto. E non è un caso che il nome scelto per un recente modello di iPad, come anche quello per i computer portatili della casa di cupertino, sia proprio air, rimando polisemico da un lato alla naturalità assorbita e dall’altro alla sua leggerezza, astrattezza, volatilità. L’iPad è sempre più sottile e se potesse diventerebbe un pensiero: non c’è più la presenza dell’oggetto perché c’è l’identificazione dell’uomo che si accultura con la merce spirituale.
Gli Apple stores sono librerie 2.0
Esemplificante in questo senso è il fatto di cronaca di qualche anno fa: l’assalto al Trony di ponte Milvio. L’assalto del 2011 al Trony di Roma, come anche le chilometriche file davanti agli Apple stores in tutte le più importanti città del mondo, da Londra a New York, da Roma a Berlino, ad ogni nuova uscita di qualsiasi prodotto della “mela morsa”, con tanto di tende fissate sull’asfalto dalla notte precedente, è in realtà il vero assalto ad una riconfigurata libreria nell’era della cultura 2.0. Persino i ceti meno abbienti sacrificano tutto per la tecnologia. Lo spazio dell’Apple store, metaforico e metonimico, diventa l’unico modo, quello indotto, quello egemonico naturalmente, che si ha per spiritualizzarsi.
La merce, ed è quel che non era riuscito a prevedere quel filosofo che nel 1942 aveva rintracciato nei gesti dell’amico le tracce di una arcaica vergogna dell’uomo di fronte alla perfezione dell’oggetto tecnico, è la chiave d’accesso non all’immortalità della tecnica, motivo per cui secondo i divi di Hollywood sarebbero i nostri modelli riuscendo nell’impresa di serializzarsi come cose, ma al sognato, onirico, letterario, mondo dello spirito.
 E se Walter Benjamin nei Passages ravvisava già, con le grandi esposizioni universali, con l’apertura dei primi grandi magazzini nelle metropoli, una mutazione nella figura del flâneur, da quello solitario per le strade di Parigi ad uno nuovo, sdradicato, che non si sente a suo agio né nella sua classe né nella sua patria, ma solo nella folla, oggi il rapporto con la merce subisce un’ulteriore mutazione. Dal collezionista che investe privatamente la cosa dei suoi sentimenti all’esibizione pubblica e fantasmagorica della merce, che investe tutta la città, oggi siamo difronte ad un ulteriore passaggio: l’acculturazione della merce come seconda pelle. La fantasmagoria della merce del flâneur di Benjamin raggiunge oggi la sua trasfigurazione.
E se Walter Benjamin nei Passages ravvisava già, con le grandi esposizioni universali, con l’apertura dei primi grandi magazzini nelle metropoli, una mutazione nella figura del flâneur, da quello solitario per le strade di Parigi ad uno nuovo, sdradicato, che non si sente a suo agio né nella sua classe né nella sua patria, ma solo nella folla, oggi il rapporto con la merce subisce un’ulteriore mutazione. Dal collezionista che investe privatamente la cosa dei suoi sentimenti all’esibizione pubblica e fantasmagorica della merce, che investe tutta la città, oggi siamo difronte ad un ulteriore passaggio: l’acculturazione della merce come seconda pelle. La fantasmagoria della merce del flâneur di Benjamin raggiunge oggi la sua trasfigurazione.
Non più l’iPad che vorrei essere per eternizzarmi ma l’iPad che vorrei essere perché è il solo modo che ho di divenire, finalmente, anche io, un poeta. Per divenire, attraverso lo schermo, io stesso Walt Whitman.
Matteo Sarlo ha scritto per diverse riviste filosofiche, di critica cinematografica, viaggi, cronaca e narrativa urbana. Ha pubblicato Passagi sul vuoto, un saggio sul concetto di «vuoto» in filosofia.




































































![POST-FOTOGRAFIE [PARTE 1]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/05/PostFotografie-620x300.jpg)





































![Black Mirror, o dell’uomo nella Postmodernità [PARTE 2]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/01/BM2-620x300.png)




![Black Mirror, o dell’uomo nella Postmodernità [PARTE 1]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/01/BM-620x300.png)
