illustrazione di Chabacolors
parole di Matteo Sarlo
Madame de Motteville racconta che un giorno, per amore del gioco, Luigi XIV regalò ad una ragazza una scatola con dentro cinque topi vivi. Doveva divertirlo vederla far saltare in aria tutto il Bon Ton e l’etichetta della corte. Urlare e agitare le mani all’aria. La ragazza, per vendicarsi, con una mano offrì da bere al re, mentre con l’altra gli mise una ranocchia sotto il naso. In una fiammata di adrenalina il re esclamò: «Ah, che canaglia!». Dopo, quasi quasi non svenne.
Ecco, quando pensate a La bella e la bestia e al mondo delle favole dovete tenere a mente questo mondo qui. Non soltanto perché per la maggior parte sono francesi. E nemmeno soltanto perché per la maggior parte sono state scritte sotto Luigi XIV. Ma per l’ingenuità dell’episodio. E per quel tipo di potenze che non hanno trovato mai una più evocativa e precisa definizione della cartesiana le passioni dell’anima.
Per inciso, Cartesio è uno che nei primi anni del seicento pensava il cosmo come autocostituentesi, anticipando di circa quattro secoli la creazione spontanea dell’universo di Hawking.
Sarà meglio dirlo subito: nella favola originale non c’è la rosa. La campana di vetro, i petali che cadono, i giorni che mancano, niente. La bella e la bestia è la storia di un ricco mercante con sei figli. Tre femmine e tre maschi. Ovviamente la figlia più bella è la protagonista, Bella, le altre due sono accidiose e fissate con l’alta società. I tre maschi sono sostanzialmente inutili, però tutto sommato buoni. Tutt’a un tratto il mercante fallisce. Dalla grande casa in città la famiglia è costretta a trasferirsi in campagna. Un vero e proprio declassamento.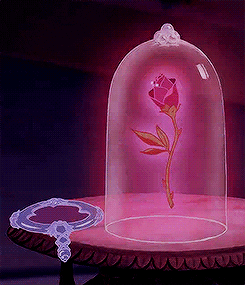
Quindi lavorare la terra, sveglia alle quattro del mattino, le stoviglie da pulire. Faceva tutto quella più carina, che era anche la più buona. Dopo si metteva a suonare il clavicembalo e a leggere libri. Un po’ troppo bucolico, ma tant’è. Siamo in una favola. Le sorelle non facevano niente: sveglia alle dieci, sbuffamenti, frecciatine all’altra, quella più giovane e capace di trovare il bello in ogni cosa. Dopo un anno che va avanti questa routine, al mercante arriva una lettera in cui sta scritto che una nave, carica delle sue mercanzie, è arrivata in porto. E lì champagne, telefonate, post su facebook. Quando il mercante è pronto per partire, le due sorelle lo pregano di portare vestiti, baveri di pelliccia, acconciature di ogni sorta per il loro ritorno in società. A Bella non serve nulla ma chiede una rosa. Non perché ci tenga più di tanto ma perché «non voleva biasimare col suo esempio le richieste delle sorelle, le quali avrebbero detto che lei non aveva domandato nulla solo per distinguersi da loro». Ah, che stile.
Il mercante arriva al porto ma i creditori riscuotono tutti i beni. E quindi dietrofront. A nemmeno 30 miglia da casa perde la strada in un grande bosco. E qui è più o meno come la versione Disney, ma senza inseguimento con i lupi. Nevica, è buio, poi vede un castello. Entra, si mangia un pollo in due bocconi. Beve un bicchiere di vino e se ne va anche a dormire. Il giorno dopo, alle dieci del mattino, trova un nuovo abito al posto del suo, che era ridotto uno straccio. Decide che è il momento di andare e esce. Però prima, in giardino, raccoglie una rosa. Poi la storia è più o meno uguale, con piccole varianti. La bestia, lo scambio, Bella che si innamora. Non ci sono gli oggetti parlanti, ma pazienza. Bella chiede di andare dal padre, ammalato per la sua partenza. E qui è un pochino diverso:
– Vi manderò da vostro padre, voi resterete lì, e la vostra povera Bestia morirà di dolore.
– No, – disse Bella piangendo, – vi voglio troppo bene per voler causare la vostra morte. Vi prometto di tornare tra otto giorni. Voi m’avete fatto vedere che le mie sorelle si sono sposate e i miei fratelli sono andati sotto le armi; mio padre adesso è solo: lasciatemi stare una settimana con lui!
– Domattina sarete a casa, – disse la Bestia; – ma ricordatevi della vostra promessa: quando vorrete tornare, non avrete che posare il vostro anello sopra il tavolino prima d’andare a letto.
Addio, Bella.
 Lei torna a casa, vengono avvertite le sorelle che arrivano di corsa insieme ai loro mariti. Quando la vedono tutta ben vestita, scoppiano d’invidia e venute a sapere di tutta la storia cercano di ritardare la partenza di Bella. «La Bestia salirà su tutte le furie nel vedere che lei non ha mantenuto la sua parola, e finalmente se la mangerà!». Alla fine, in parte ci riescono in parte no. Trattengono Bella qualche giorno in più ma poi mette l’anello sul tavolino e si addormenta di sasso. La mattina trova la bestia morente:
Lei torna a casa, vengono avvertite le sorelle che arrivano di corsa insieme ai loro mariti. Quando la vedono tutta ben vestita, scoppiano d’invidia e venute a sapere di tutta la storia cercano di ritardare la partenza di Bella. «La Bestia salirà su tutte le furie nel vedere che lei non ha mantenuto la sua parola, e finalmente se la mangerà!». Alla fine, in parte ci riescono in parte no. Trattengono Bella qualche giorno in più ma poi mette l’anello sul tavolino e si addormenta di sasso. La mattina trova la bestia morente:
– Avete dimenticato la vostra promessa; il dolore di avervi perduta mi ha spinto a lasciarmi morire di fame, ma adesso muoio contento, perché ho avuto il piacere di rivederci ancora una volta.
– Ma no, mia cara Bestia, voi non morrete! – gli disse Bella, – voi dovete vivere per diventare mio marito: fin da questo istante vi do la mia mano e giuro che non sarà d’altri che vostra. Ahimè! Credevo di provare per voi soltanto una buona amicizia, ma il dolore che sento mi fa capire che non potrei più vivere senza vedervi!
Ovviamente Bella non finisce nemmeno di dichiararsi che il castello prende a brillare: fumi, fuochi, musica. La Bestia si trasforma in un principe. Una fata l’aveva condannato – lo veniamo a sapere soltanto ora, al contrario della versione Disney, che preferisce giocare subito a carte scoperte – a restare un mostro finché una donna non avesse acconsentito a sposarlo.
La fata appare e si rivolge a Bella. E qui sta la morale:
Venite a ricevere il premio dell’ottima scelta che avete fatta; voi avete preferito la virtù alla bellezza, e anche allo spirito: meritate di trovare tutte queste doti riunite in una sola persona.
Quanto alle sorelle, la fata le trasforma in statue. Conserveranno però intatta la coscienza di donne, sotto la pietra. Staranno mute per l’eternità alla porta del palazzo, ad osservar la felicità di Bella. FINE.
Madame Le Prince de Beaumont l’ha scritta un po’diversa dalla Disney ma la morale al fondo rimane: la bellezza non risiede nelle apparenze, perché la verità si coglie col cuore. Con il cuore, vale a dire non con gli occhi. La verità allora, d’accordo con Platone, è accessibile unicamente attraverso una sorta di intuizione che sola permette il salto dai sensi e perfino dall’intelligenza (alla bestia era stato impedito dalla fata di mostrarsi anche intelligente, cosa tagliata nella versione moderna). Ma quando parliamo di Bellezza di cosa stiamo parlando? Nient’altro che del problema della Verità. Perché la morale della favola, come anche del cartone e del film della Disney, è semplice: la Verità delle cose si trova al di là dell’apparenza. Verità e apparenza sono contrari. La seconda va scavalcata, o attraversata, per arrivare alla prima. Non è banale. Ed è stato esattamente il fondamento di tutta la metafisica classica, da Platone a Kant.
Il perno della nota disputa tra Kant ed Hegel è tutta qui: ci credo o non ci credo alla Bella e la bestia? Hegel non ci crede. Il grande filosofo tedesco inizia il secondo volume della Scienza della Logica – la logica dell’essenza – dedicandosi proprio a questo problema. Leggerlo è un po’ come sapere cosa Hegel avrebbe detto uscito dal cinema dopo aver visto Emma Watson:
L’essere è l’immediato. In quanto il sapere vuole conoscere il vero, quello che l’essere è in sé e per sé, esso non rimane all’immediato e alle sue determinazioni, ma penetra attraverso quello, nella supposizione che dietro a quell’essere vi sia ancora qualcos’altro che non l’essere stesso, e che questo fondo costituisca la verità dell’essere.
E fin qui Hegel riporta il modus operandi della metafisica classica, praticamente la riscrittura dei primi 3 minuti del cartone Disney: se vuoi raggiungere la verità, dovrai conquistarla. Dovrai penetrare attraverso le apparenze, scavalcarle, per meglio guardarne il segreto. E poi aggiunge:
La lingua tedesca ha conservato l’essenza (Wesen) nel tempo passato (gewesen) del verbo essere (sein); perocché l’essenza è l’essere che è passato, ma passato senza tempo.
[…] Ma questo andare è il movimento dell’essere stesso. Si mostrò nell’essere, che per sua natura esso s’interna, e che con questo andare in sé diventa l’essenza.
 Tradotto: Per lui non ha senso pensare l’essere, l’immediato, che nel suo linguaggio è tutto ciò che salta agli occhi con evidenza, il fenomeno, il mondo per come ci appare, e dall’altra parte l’essenza di quel mondo (cfr. Kant, il quale li pensava tanto diversi strutturalmente da dichiarare l’uno oggetto di scienza e conoscenza certa mentre l’altro oggetto di fantasticherie). Non ha senso pensare essere ed essenza come molecolarmente separati. Piuttosto l’essere e l’essenza sono due declinazioni della stessa cosa. E la seconda è il risultato del movimento della prima. Eppure per lui ogni punto dell’immediato, nel percorso di questo movimento, è già una stazione della verità. L’oggetto geometrico che più chiarisce questo punto è il frattale (il cavolo è un caso di frattale in natura). Allora non ha ragione la fata: l’essenza non è contraria all’apparenza. Essa non può darsi se non nel suo apparire.
Tradotto: Per lui non ha senso pensare l’essere, l’immediato, che nel suo linguaggio è tutto ciò che salta agli occhi con evidenza, il fenomeno, il mondo per come ci appare, e dall’altra parte l’essenza di quel mondo (cfr. Kant, il quale li pensava tanto diversi strutturalmente da dichiarare l’uno oggetto di scienza e conoscenza certa mentre l’altro oggetto di fantasticherie). Non ha senso pensare essere ed essenza come molecolarmente separati. Piuttosto l’essere e l’essenza sono due declinazioni della stessa cosa. E la seconda è il risultato del movimento della prima. Eppure per lui ogni punto dell’immediato, nel percorso di questo movimento, è già una stazione della verità. L’oggetto geometrico che più chiarisce questo punto è il frattale (il cavolo è un caso di frattale in natura). Allora non ha ragione la fata: l’essenza non è contraria all’apparenza. Essa non può darsi se non nel suo apparire.
Certo è che il modo di ragionare di Hegel è piuttosto anticonvenzionale. E Walt Diseny nel contrapporre, ancora una volta, opinione, principe che si fida delle apparenze, doxa, contro conoscenza certa, la bellissima fata che insegna a guardare al di là, episteme, ha antenati illustri. Per esempio? Per esempio il cosmo platonico: le idee da una parte (che portano a conoscenza certa, utilizzata dalla bellissima fata) e le cose dall’altra (che portano all’opinione, di cui si fida il Principe). Il novecento, e la scuola fenomenologica, tenta di far saltare in aria questa struttura di pensiero. La verità non esiste se non nel suo manifestarsi. Così in Introuduzione alla metafisica, Martin Heidegger può affermare che la verità non è altro se non l’uscire fuori di se stessa dalla latenza, la verità è l’atto stesso di svelarsi. Perché l’essere, la verità, il paradigma ideale separato è, con Nietzsche, morto. Ma Hegel e Heidegger non sono bastati contro Walt Disney. E se da parte della Bella e la bestia c’è Platone, da parte di Nietzsche c’è il Time.
 In una recente copertina, il settimanale americano se lo chiede esplicitamente: la verità, è morta?
In una recente copertina, il settimanale americano se lo chiede esplicitamente: la verità, è morta?
Il riferimento è naturalmente politico. Cioè l’operazione di mascheramento della verità nell’epoca trumpista. Ma la domanda tiene anche da un punto di vista filosofico. La politica è ovviamente il primo mondo dove si manifesta la chiusura delle grandi narrazioni e la caduta del grande logos, anche senza andare oltreoceano: quel che sta accadendo oggi in Italia sarebbe dovuto, secondo lo psicanalista Massimo Recalcati, alla caduta del Padre, cioè dell’ordine dei significanti, a quello che Lacan chiama l’Altro o Ordine Simbolico. Cioè, ancora una volta, la scomparsa della Verità.
Ma che cosa vuol dire mascherare la verità? Non è ogni forma di racconto, quindi anche il racconto della Verità, già di per sé narrazione? Verità e finzione sono davvero due cose differenti, come li vuole il pensiero metafisico classico? O forse i confini dell’uno sono i limiti dell’altro?
Se c’è un libro che segna una frattura tra classicità e modernità, quello è Il discorso sul Metodo (1637), Cartesio. Scritto volutamente in francese e non in latino, ha fondato l’idea moderna di sapere contro un certo tipo di aristotelismo. Un’opera capitale. Oggi non c’è dubbio: chiunque ne voglia entrare in possesso, al netto di Kindle, book reader e Amazon, deve andare in libreria e cercarlo nel reparto filosofia. Ma è curioso che a gli occhi di chi lo ha scritto, Il discorso sul metodo sia fiction.
poiché propongo questo scritto come una storia (historie), o se preferite, una favola (fable)…
Una historie. Un termine che Cartesio prende in prestito da Jean-Louis Guez de Balzac, che il 30 marzo 1628 lo pregava di ricordarsi della storia (historie) della sua anima. È Cartesio ad aggiungere però il termine favola (fable). Nell’uso corrente fiction, per noi italiani, non è altro che la traduzione in lingua inglese di narrativa come genere letterario. Dunque una trama, una costruzione finta. Inventata. Fiction è però legato al participio passato del verbo latino fingere, cioè fictum. Fictae, guarda caso, è un aggettivo che viene molte volte riferito alle Fabulae. Ma non soltanto gli uomini fingunt. Secondo Cicerone (De Officiis) le api fingunt il favo modellando la cera. Plauto nello Stichus collega ficta con i trucchi delle donne, che ingannano l’aspetto. Allora come le api fingunt il favo, come le donne fingono il proprio volto, così il poeta finge la propria fabula. La fabula non è qualcosa di inventato, né tantomeno falso, è qualcosa di sottoposto a manipolazione e trattamento. Esattamente quel che accade in La bella e la bestia. O meglio, quello che accade nella favola dentro la favola. E qui la Disney supera l’originale, la copia supera il modello. Perché ne capisce la potenza dell’anima e la moltiplica, la serializza. Non si trasforma più soltanto il castello e il principe/bestia. La metamorfosi non è più soltanto quella uomo-animale; tutti i partecipanti del castello sono soggetti a mutazione, una ancora più particolare: uomo-cosa. Nel film è quello che accade a Ewan McGregor, Emma Thompson, Stanley Tucci e via dicendo. Ma la fiaba è sempre un luogo di variazione e depistamento. E ce n’è una che è esattamente il rovescio del racconto di Madame le Prince de Beaumont: Cenerentola di Charles Perrault.
Anche Cenerentola è una storia sulle apparenze e smascheramenti. È una narrazione sul fraintendimento che procura la vista, seppure di segno opposto. Questa volta l’inganno permette la verità. E mentre in La bella e la bestia il mondo – il castello, cioè il mondo che conta per la storia –, è mascherato dall’incanto, tanto da rischiare di scomparire, di divenire meno che niente, in Cenerentola l’elemento magico realizza la realtà. La fictio cura il reale. La finzione realizza la realtà. Allora da che parte stare, Bella o Cenerentola?
Matteo Sarlo ha scritto per diverse riviste filosofiche, di critica cinematografica, viaggi, cronaca e narrativa urbana. Ha pubblicato Passagi sul vuoto, un saggio sul concetto di «vuoto» in filosofia





































































![POST-FOTOGRAFIE [PARTE 1]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/05/PostFotografie-620x300.jpg)





































![Black Mirror, o dell’uomo nella Postmodernità [PARTE 2]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/01/BM2-620x300.png)




![Black Mirror, o dell’uomo nella Postmodernità [PARTE 1]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/01/BM-620x300.png)
