illustrazione di Matteo Sarlo
parole di Matteo Sarlo
Eugene “Bucky” Cantor è un professore di ginnastica: atletico, ben proporzionato e con un difetto alla vista che lo esclude dal servizio militare. Eugene “Bucky” Cantor è stato cresciuto dai nonni. Madre morta dopo il parto e padre in galera. Eugene “Bucky” Cantor è però più di tutto questo. Eugene “Bucky” Cantor è l’ultimo personaggio di Philip Roth.
È il 2010 e Roth scrive l’ultimo di quei quattro romanzi brevi che, tutti insieme, la Library of America raccoglie sotto il nome di Nemeses: Everyman, Indignation, The Humbling, Nemesis. Poi deciderà di smettere. Non scrivere più, finirla con quella – la scrittura – che forse a torto la psicanalisi ha individuato come forma di sublimazione per ecellenza. Prima di smettere però Roth decide di concentrare il fuoco della narrazione su un’epidemia, la fisicità del male e i suoi effetti. Quella ferocia degli accidenti che procedono irrelati privi di un telos che li direzioni. Un morbo – la poliomielite –, condiviso ed esteso a macchia d’olio sulla cittadina di Newark.
 Dal suicidio, privato, minuto, personale diremmo, sul terrazzo di un appartamento di New York di Simon Axler (The Humbling), dall’uscita volontaria del fantasma Zuckerman (Exit Ghost) e dall’uccisione del diciannovenne Marcus Messner tra le baionette coreane (Indignation), alla pestilenza che inonda un campo estivo di bambini. In altri termini, dall’individuo al collettivo. Dall’unità alla molteplicità. Sembra compiersi quel salto per cui a Roth, vincitore di ogni genere di premio letterario, dai tre Pen Faulkner Award al Saul Bellow Award al premio Pulitzer per elencarne sono alcuni, è sempre stato negato il Nobel per la Letteratura. La colpa sarebbe una scrittura troppo inchiodata sull’individuo, che racconta problemi non universali ma solo di certi uomini, perlopiù vecchi e statunitensi. Eppure, in un’ironia “rothiana”, se alla malattia e alla paura della sua diffusione partecipano un gruppo d’individui, una collettività, non per questo la fenomenologia del male, sempre materiale e concreto e mai teologico o metafisico, in una miriade di
Dal suicidio, privato, minuto, personale diremmo, sul terrazzo di un appartamento di New York di Simon Axler (The Humbling), dall’uscita volontaria del fantasma Zuckerman (Exit Ghost) e dall’uccisione del diciannovenne Marcus Messner tra le baionette coreane (Indignation), alla pestilenza che inonda un campo estivo di bambini. In altri termini, dall’individuo al collettivo. Dall’unità alla molteplicità. Sembra compiersi quel salto per cui a Roth, vincitore di ogni genere di premio letterario, dai tre Pen Faulkner Award al Saul Bellow Award al premio Pulitzer per elencarne sono alcuni, è sempre stato negato il Nobel per la Letteratura. La colpa sarebbe una scrittura troppo inchiodata sull’individuo, che racconta problemi non universali ma solo di certi uomini, perlopiù vecchi e statunitensi. Eppure, in un’ironia “rothiana”, se alla malattia e alla paura della sua diffusione partecipano un gruppo d’individui, una collettività, non per questo la fenomenologia del male, sempre materiale e concreto e mai teologico o metafisico, in una miriade di 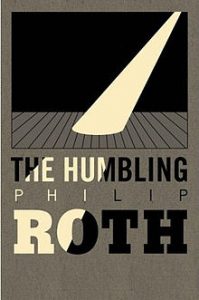 dettagliati sintomi che ricordano le descrizioni dei palazzi di John Updike, è meno filtrata dal singolo. Dalla storia di ciascun bambino del parco divertimenti di cui il ventitreenne Bucky è il direttore. Dalla storia dei loro genitori, della madre che non ha conosciuto e della prigionia del padre. Della sua fidanzata Marcia e del padre di lei, medico e razionale come un Voltaire. Persino della più rinomata vittima: Franklin Delano Roosevelt.
dettagliati sintomi che ricordano le descrizioni dei palazzi di John Updike, è meno filtrata dal singolo. Dalla storia di ciascun bambino del parco divertimenti di cui il ventitreenne Bucky è il direttore. Dalla storia dei loro genitori, della madre che non ha conosciuto e della prigionia del padre. Della sua fidanzata Marcia e del padre di lei, medico e razionale come un Voltaire. Persino della più rinomata vittima: Franklin Delano Roosevelt.
Sono come piombo le parole di Nathan Zuckerman in American Pastoral: “La gente pensa che la storia abbia il respiro lungo, ma la storia, in realtà, ti si para davanti all’improvviso”. E mentre va scrivendo della Polio, Roth legge La peste di Albert Camus.
Il contesto della polio, chiara opportunità per descrivere la condizione di noi umani senza difese o barriere o mura a protezione di una integrità tutta da verificare, è inserito in una precisa struttura narrativa e temporale scandita da chiare e puntuali sequenze: 1. descrizione del luogo, inizialmente un quartiere italiano nel 1944, lontano dal campo estivo dove insegna l’atletico Bucky,
The first case of polio that summer came early in June, right after Memorial Day, in a poor Italian Neighborhood crosstown from where we lived.
2. passa ai sintomi, alla modalità del contagio. 3. Segue un’analisi dei comportamenti umani difronte alla pestilenza e degli effetti prodotti dal morbo sul sistema morale, sulle istituzioni e sulla responsabilità delle proprie azioni sino 4. alle responsabilità di Dio.
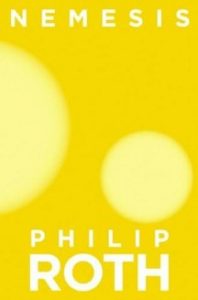 Lontano dalle riflessioni su rapporti tra la vita e l’arte di un Nathan Zuckerman o anche di un Peter Tarnapol o, anche, di un David Kepesh, Bucky è un semplice professore di ginnastica che deve stare attento alle ragazzine che saltano con la corda e ai maschietti che giocano a pallone. Come Marcus Messner, Bucky Cantor è un ragazzo con il senso del dovere schiacciato dal carrarmato della Nemesi, la storia ultra-individuale che, vicina al fato, all’ananke, calpesta cecamente la gracile sopravvivenza del soggetto. È Michiko Kakutani a rilevare, con polemica, come ciò che avvicina più Marcus Messner a Eugene Bucky Cantor è la loro niceness. “Cantor non è lacerato- scrive-, come molti personaggi di Roth, tra le responsabilità e la trasgressione, tra la tradizione e la ribellione. Non ha nemmeno il senso dell’humor- non fa uso di ironia o sarcasmo, e scherza raramente. Laddove Portnoy’s Complaint è un racconto oltraggiosamente comico su come sbarazzarsi dei doveri, Nemesis si può dire sia una parabola sulla coscienza”.
Lontano dalle riflessioni su rapporti tra la vita e l’arte di un Nathan Zuckerman o anche di un Peter Tarnapol o, anche, di un David Kepesh, Bucky è un semplice professore di ginnastica che deve stare attento alle ragazzine che saltano con la corda e ai maschietti che giocano a pallone. Come Marcus Messner, Bucky Cantor è un ragazzo con il senso del dovere schiacciato dal carrarmato della Nemesi, la storia ultra-individuale che, vicina al fato, all’ananke, calpesta cecamente la gracile sopravvivenza del soggetto. È Michiko Kakutani a rilevare, con polemica, come ciò che avvicina più Marcus Messner a Eugene Bucky Cantor è la loro niceness. “Cantor non è lacerato- scrive-, come molti personaggi di Roth, tra le responsabilità e la trasgressione, tra la tradizione e la ribellione. Non ha nemmeno il senso dell’humor- non fa uso di ironia o sarcasmo, e scherza raramente. Laddove Portnoy’s Complaint è un racconto oltraggiosamente comico su come sbarazzarsi dei doveri, Nemesis si può dire sia una parabola sulla coscienza”.
Il giovanissimo professore di ginnastica sembra essere baciato dalla sorte: è professore a soli ventitré anni, è un bel ragazzo, ha una fidanzata molto carina anch’essa professoressa, lontana dal contagio, ad Indian Hill ed è un idolo per i suoi ragazzi. Per come gioca con loro e per come in un pomeriggio di caldo torrido ha respinto due macchine piene di Italiani tra i quindici e i diciotto anni provenienti dal East Side High, primo luogo infettato dalla polio, venuti al campo per diffondere la malattia. Perché anche gli altri patiscano le loro sofferenze.
Dopo l’incidente con gli Italiani, agli occhi dei bambini del campo, diventerà un eroe a tutti gli effetti, un “eroic older brother”, special modo per quelli il cui fratello più grande è a combattere in guerra. E poi, i primi due casi di “polio” del quartiere, Herbie e Alan:
It was later in the week that two of the boys who’d been at the playground when the Italians had come around didn’t show up for a few days to play ball.
Bucky cerca di tenere tutto sotto controllo, di non diffondere anche un altro male- la paura- al morbo che già va dilagando nel quartiere. Sa che non è per gli italiani che il male si è diffuso nel suo campo. Perché, come si troverà a dire in una conversazione telefonica a Marcia,
The Italian didn’t spread anything. I was there. I know what happened […] Polio is Polio- nobody knows how it spreads. Summer comes and there it is, and there’s nothing much you can do.
Gli italiani non c’entrano niente. E nessuno sa quale sia la causa e, soprattutto, non c’è nulla che tu possa fare.
Bucky Cantor, con tutto il suo carico di responsabilità, la sua pacatezza, i suoi comportamenti puri da americano modello, è un uomo di quarant’anni quando ne ha solo ventitré.
Il paradosso è evidente; il giovane professore di educazione fisica si muove in controtendenza rispetto a quella immaturity affinata nel corso degli anni dal massimo alter-ego di Roth, Nathan Zuckerman, come anche dall’attore newyorkese che “had lost his magic”, Simon Axler, ma come, ancora, pressoché tutti i personaggi di Roth, da David Kepesh a Coleman Brutus Silk, che decide di vivere, irrazionalmente e irresponsabilmente la sua “scandalosa” relazione con Faunia Farley. È lo stesso Roth in effetti, in Reading Myself and Others a scrivere che:
I set myself the goal of becoming the writer some Jewish critics had been telling me I was all along: irresponsible, consciousness, unserious.
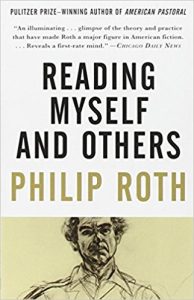 Nessun altro ha lavorato così duramente e con così tanta precisione quanto Philip Roth “solo” per essere immaturo. Ma perché questo esercizio, allenarsi all’immaturità? È un atteggiamento alla dandy o in nome di un edonismo del XX secolo? È una rinuncia o una resa? O forse non sarebbe meglio parlare di una “matura immaturità”? Non è un caso che proprio i due personaggi più giovani nella serie delle novelle brevi, vale a dire Marcus Messner e Eugene Bucky Cantor siano portatori di quei valori tutti votati ad un Etica, diremmo, con la “e” maiuscola, pure se, al contrario di quello che scrive la Kakutani, nella vistosa differenza di un finale scelto da un’azione, il pugno sbattuto sulla scrivania del preside, e uno, come vedremo, subìto nella rinuncia all’azione. Come che per raggiungere quella frivolezza di comportamenti di Coleman o Nathan sia necessario raggiungere una leggerezza di pensiero che arriva solo successivamente una vissuta e verticale serietà. Come che il “being-immaturity” non sia una post-moderna superficialità che si sposta in orizzontale in pieno stile da spot pubblicitario ma una decisione, l’ultima grande decisione, di opposizione alla società. Secondo il paradosso adorniano che, in riferimento all’arte nella sua “Teoria estetica”, arriverà ad affermare che il più grande contributo alla società è la resistenza alla società. Marcus e Bucky non sono nemmeno, in un rovesciamento del rovesciamento, più superficiali di Nathan Zuckerman. Sono solo più giovani. E non hanno avuto il tempo per affinare una risposta a quelle tendenze social-culturali che dettano comportamenti e prescrizioni. Marcus ha avuto il tempo per scontrarsi unicamente con quelli religiosi del decano Caudwell e Eugene, vedremo, dovrà fare i conti, forse troppo presto per formulare una sua contro-azione, con dettami ben più grandi, quelli del fato al quale non crederà. Ai quali vorrà continuare a cercare una spiegazione finendo per punirsi, questa volta sì irresponsabilmente e senza ragione. Scivolando nella contraddizione di una responsabilità scriteriata che si farà carico di quelle colpe che non sono né sue né di Dio, ma, più atrocemente, del grande Nulla che tutto inghiotte e che gestisce gli eventi giocando a dadi, senza nessun perché e relazione.
Nessun altro ha lavorato così duramente e con così tanta precisione quanto Philip Roth “solo” per essere immaturo. Ma perché questo esercizio, allenarsi all’immaturità? È un atteggiamento alla dandy o in nome di un edonismo del XX secolo? È una rinuncia o una resa? O forse non sarebbe meglio parlare di una “matura immaturità”? Non è un caso che proprio i due personaggi più giovani nella serie delle novelle brevi, vale a dire Marcus Messner e Eugene Bucky Cantor siano portatori di quei valori tutti votati ad un Etica, diremmo, con la “e” maiuscola, pure se, al contrario di quello che scrive la Kakutani, nella vistosa differenza di un finale scelto da un’azione, il pugno sbattuto sulla scrivania del preside, e uno, come vedremo, subìto nella rinuncia all’azione. Come che per raggiungere quella frivolezza di comportamenti di Coleman o Nathan sia necessario raggiungere una leggerezza di pensiero che arriva solo successivamente una vissuta e verticale serietà. Come che il “being-immaturity” non sia una post-moderna superficialità che si sposta in orizzontale in pieno stile da spot pubblicitario ma una decisione, l’ultima grande decisione, di opposizione alla società. Secondo il paradosso adorniano che, in riferimento all’arte nella sua “Teoria estetica”, arriverà ad affermare che il più grande contributo alla società è la resistenza alla società. Marcus e Bucky non sono nemmeno, in un rovesciamento del rovesciamento, più superficiali di Nathan Zuckerman. Sono solo più giovani. E non hanno avuto il tempo per affinare una risposta a quelle tendenze social-culturali che dettano comportamenti e prescrizioni. Marcus ha avuto il tempo per scontrarsi unicamente con quelli religiosi del decano Caudwell e Eugene, vedremo, dovrà fare i conti, forse troppo presto per formulare una sua contro-azione, con dettami ben più grandi, quelli del fato al quale non crederà. Ai quali vorrà continuare a cercare una spiegazione finendo per punirsi, questa volta sì irresponsabilmente e senza ragione. Scivolando nella contraddizione di una responsabilità scriteriata che si farà carico di quelle colpe che non sono né sue né di Dio, ma, più atrocemente, del grande Nulla che tutto inghiotte e che gestisce gli eventi giocando a dadi, senza nessun perché e relazione.
Non è solo una passeggiata per il puro piacere di camminare (“an aimless stroll”) in una calda notte estiva ma sta puntando in maniera molto chiara la casa di Marcia. Non è evidente nella mente di Bucky finché non vi si trova davanti. Ora sa di voler vedere quella casa, ma non ancora il perché.
Maybe his intention was simply to look at the big brick house stranding amid the other large brick houses flanking it and think of her and turn around and head back where he’d come from. But after circling once around the block, he found himself just paces from the Steinberg door, and with resolve he headed up the flagstone walk to ring the bell […] It was Dr. Steinberg who came to the door. Now he knew why he’d been roaming far from the tenements of Barclay Street, breathing in this stinking air.
Forse il motivo non è la vista di quei mattoni che riattivi il ricordo di un amore lontano. Non una forma di nostalgia ma una disperazione più atavica. È lì perché deve parlare con il padre di Marcia, il Dr. Steinberg. Perché Bucky ha visto morire due suoi alunni di dodici anni e ha bisogno di un sapere scientifico, tecnico, che lo aiuti a mettere insieme i pezzi. Prima della passeggiata una madre lo aveva chiamato addossandogli la colpa della morte del figlio. Era colpa sua se teneva aperto quel campo estivo dove l’epidemia ha potuto prendere corpo. Era colpa sua se il figlio si era ammalato, andando incontro alla paralisi e alla morte. Come riconosce il Dr. Steinberg: “it’s a lot of responsability for you looking after all those boys. This Epidemic must be a great weight on your shoulders”. Ma il problema è che Bucky non sa se sta facendo la cosa giusta ed è proprio per questo motivo che si trova a casa di Marcia. La risposta del dottore fa uso di percentuali, di calcoli e di verità razionali come uno Sherlock Holmes che si trovasse difronte all’impossibilità di un caso:
a doctor runs into that too. You’re right- people in great pain become hysterical and, confronted with the injustice of illness, they lash out. Nut boy’s playing ball doesn’t give them polio. A virus does. We may not know much about polio, but we know that. Kids everywhere pay hard out of doors all summer long, and even in an epidemic it’s a very small percentage who become infected with the disease. And a very small percentage of those who get seriously ill from it. and a very small percentage of those who die.
Una piccolissima percentuale di bambini che giocano a pallone al parco viene infettata. Di questa piccolissima parte un’altra piccolissima parte è quella che si ammala seriamente. Infine, di questa è un’ulteriore microscopica parte che arriva alla morte. Il dottore stava seduto su una sedia a dondolo di vimini fumando la sua pipa dall’aspetto antico, gestendo con abilità clinica ogni domanda del povero Eugene come il giocatore di basket i rimbalzi del pallone sotto il palmo della mano. Fino a quando le domande non diventano: perché l’epidemia è più grave nella parte di Weequahic? Come è potuto essere?
Ma nessuno sa dove nasca la polio. “polio is still a mysterious disease”. È al di là della sua coscienza. È al di là delle sue responsabilità. Allora Bucky ha pensato di chiedere se Dio non avesse una coscienza, e dove comincino le sue di responsabilità, o invece conosce limiti? Ma invece chiede: “should be playground be shut down?”
È chiaro: la polio è il correlato simbolico della pochezza umana. Della sua vita nuda e senza redenzione. Esposta al turbinio degli accidenti e mai delle sostanze. Perché di sostanze, propriamente parlando, non se ne vede nemmeno l’ombra, in nessun romanzo di Roth. Un essere irrelato che è per se e per sé si concepisce. Ne consegue una visione delle cose in cui restiamo solo cechi ingranaggi di un meccanismo senza costruttore. Il morbo, il male, la materialità dei sintomi, l’affinata descrizione di tante solitudini –la vita di un uomo come la goccia sul becco di un lavandino- rende conto di quella dimensione originaria di senso e non-senso del mondo. Sono tante le domande che spuntano, come teste di conigli dalla terra, nella mente di quel professore di educazione fisica. Tutte riguardano la ragione, il fondamento che permette l’epidemia e la sua esistenza. E perché colpisce solamente in estate? Si è anche chiesto, il povero professore di ginnastica che di arte e di letteratura e di epistemologia non si è mai occupato, come invece i suoi “cugini” Nathan e Coleman, se non sia il sole stesso la fonte del male. In un rovesciamento inconsapevole della tradizionale immagine; se, dal cristianesimo sino alla cultura umanistica trecentesca, passando anche per la più moderna e foscoliana, il sole è simbolo della vita e della sua genesi, nelle pagine di Nemesis si attua una conversione per cui è la luce, principio illuministico di conoscenza, e il calore, ciò che mantiene l’essere, e l’estate, stereotipo della spensieratezza, a farsi scaturigine della morte.
Nemesis e American Pastoral. Accomunati non solo per il luogo ma per quello “svedese” dalla mascella quadrata, biondino con gli occhi azzurri e “dall’inerte maschera vichinga”, padre spirituale che il ventitreenne Eugene Cantor non ha mai avuto. Tutti e due condividono una ingenuità, il sogno di una serenità pastorale scalzata via sotto i “colpi secchi che battono sulla porta della sventura” (A. Camus, Lo Straniero)
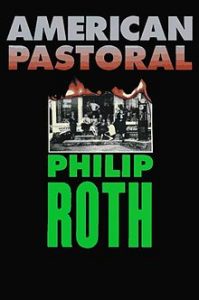 Ma chi è Seymour Levov che fa rima con Love– come intonano le ragazze pon-pon a bordo campo?
Ma chi è Seymour Levov che fa rima con Love– come intonano le ragazze pon-pon a bordo campo?
La storia di quella ricercata e immateriale ingenuità americana del farsi da sé è raccontata attraverso la mediazione di Nathan Zuckerman, narratore intradiegetico. Nathan raccoglierà il testimone di un uomo, lo svedese, “tradito all’improvviso da un corpo meraviglioso che gli aveva dato solo sicurezza e che aveva costituito il nocciolo del suo vantaggio sugli altri, che aveva perso momentaneamente l’equilibrio e si era aggrappato, fra tutti, proprio a me, come se così potesse in qualche modo far rivivere il padre defunto ed evocarne la forza protettrice.” Ma non è solo per questo, non è per rievocare il padre. Poi continua: “lo svedese vuole che qualcosa resti. Ecco perché si è rivolto a me: per registrare ciò che, altrimenti, potrebbe essere dimenticato. Omesso e dimenticato. Che cosa poteva essere?” (P. Roth, Pastorale Americana)
È necessario fermarsi un poco e contestualizzare; Roth ritorna nel dopoguerra, negli anni cinquanta americani, in un momento in cui l’assimilazione degli ebrei in America era al suo apice, il paradiso una palpabile realtà e, come scrive Ross Posnock “the Triumph of the untragic appeared to be at hand.”
Eccolo quell’atletico Levov-Bucky, sedotto (e seduzione al tempo stesso) dal non-tragico possibile, motore della fede americana nel trionfo dopo (nel caso di Levov) e contro (nel caso di Bucky) il travaglio della guerra mondiale. Entrambi pensano ad una ancora possibile esistenza arcadica, naturale, dove ad un’azione corretta corrisponde un effetto positivo, dove l’autoaffermazione e l’identificazione di sé sono valori sentiti al pari di potenze naturali. Dove l’imperativo è la non-contaminazione, la ricerca di uno spazio di inespugnabilità per poter costruire la propria fortezza, lontano dagli altri e al riparo dagli altri. Non consapevoli, però, che è proprio accettando lo sguardo dell’altro che si può plasmare il proprio. Che è solo attraverso gli altri sé che si arriva alla propria “determinazione”. E dimentichi, ad ogni modo, che il mondo è pieno di ostacoli, naturali e soprattutto culturali. Eroi moderni più che uomini post-moderni, saranno costretti a curvare la propria schiena di giganti per entrare nella porticina nana di una contro-pastorale; quella della figlia del primo, Merry, e quella epidemica di Bucky, che sporca e sgualcisce il disegno sulla sabbia di entrambi.
Ardie Mesnikoff, e il racconto dell’eroe incompleto
Come per lo svedese Levov che fa rima con “love” anche per Bucky Cantor c’è un aedo, un narratore, un medium delle sue gesta. Dato che avvicina entrambi a due eroi epici contro il proprio tempo, le quali gesta non venivano cantate da se stessi, perché occupati a compiere grandi azioni, ma sempre da qualcun altro che, da lontano, riportava alla memoria, non a caso l’invocazione costante alle muse, figlie di Mnemosine – Memoria-, le erga di uomini che si ergevano contro il destino, il fato, l’ananke, e, ci siamo, la Nemesi. Se l’aedo dello Svedese è l’illustre Nathan Zuckerman in persona, quello di Bucky è Ardie Mesnikoff. Ne veniamo a conoscenza dopo circa cento pagine- centootto nella prima edizione.
The next morning was the worst so far. Three more boys had come down with polio- Leo Feinswog, Paul Lippman, and me, Arnie Mesnikoff.
Ardie è uno dei bambini infettati al campo e che ora, a distanza di decenni, racconta la storia di quel professore di ginnastica che lanciava il giavellotto come nessun altro.
Bucky ha resistito a lungo nel campo estivo di Newark. Resisteva come i suoi amici resistevano nella guerra in Europa in cui lui non ha potuto arruolarsi. Combatteva sul fronte interno contro un avversario più temibile del fuoco nemico che sparava sui due suoi più cari amici. Finché Marcia non gli mette pressione perché la raggiunga e lo implora di andare da lei, ad Indian Hill. Lì non c’è pericolo che venga infettato. Potranno passare l’estate insieme e poi sposarsi. Sulle prime, il senso di responsabilità dell’eroe lo incatena al suo campo. Resiste. Poi, un giorno decide di partire. Decide di salvare se stesso e abbandonare i ragazzi.
Parlare con Marcia al telefono, la telefonata in cui lui collassa e decide di raggiungerla, lo aveva reso capace di pensare un mondo di sicurezza e prevedibilità e di appagamento verso una “normal life lived in normal times”. Ma non appena riaggancia, si pente l’eroe: “How could have done what he’d just done?”
Raggiunto Indian Hill, si apre la descrizione di un idillio, di contro all’inferno dei fatti accaduti nella cittadina di Newark, in Normandia o nel Pacifico. Bucky è l’insegnante di tuffi, la sera sale su una canoa con Marcia e trascorrono le notti su un’isoletta di betulle bianche tutta per loro.
Segue quello che secondo Coetzee è il “segreto”, necessario da svelare, per addentrarsi nel romanzo: Bucky Cantor è un portatore sano di polio. Un “healthy infected carrier”. Inconsapevolmente ha contribuito al contagio nel campo estivo di Newark e ora i primi casi anche ad Indian Hill. Uno di questi è la sorella, une delle due gemelle, proprio di Marcia. Aveva portato la polio anche qui, in questa pastorale idilliaca insieme a Marcia finendo anche lui vittima di una delle forme più gravi del morbo, pur rimanendo vivo. Una gamba andata e un braccio destro malconcio. Ciononostante, la ragazza lo va a trovare all’ospedale, ripetutamente, perché vuole sposarlo. Il suo amore non è cambiato solo per un braccio ed una gamba. Ma lui rifiuta. Rinuncia ad una ragazza bellissima. Dipiù; rinuncia a qualsiasi relazione, da quel giorno sino alla sua vecchiaia. Sceglie di non vivere più, tenendo fede alla sua ingenuità razionale da eroe tragico che non accetta la tragedia.
That the polio epidemic among the children of the Weequahic section and the children of Camp Indian Hill was a tragedy, he could not accept. He has to convert tragedy into guilt.
C’era un’epidemia e doveva trovare una ragione che la spiegasse. Come gli rimprovererà Marcia, non riesce a pensare all’epidemia se non come una colpa, o sua o di Dio. Eccolo, secondo le parole di Andy Mesnikoff , “il maniaco del perché”. Lui che un tempo era “l’uomo più felice della terra”. Lui che si è battuto, più di ogni altro, affianco ai bambini del campo perché non si facessero prendere dalla paura e dal terrore, lui che su quel fronte interno funzionava da generale contro un male più terrificante delle truppe naziste, proprio lui è il distruttore, la fonte dalla quale sgorga l’epidemia. La Nemesi si scaglia contro l’eroe che non sopporta il caso, l’insensatezza, l’incongruo, il tragico. Proprio come lo svedese di fronte alla figlia, proprio lui che aveva fatto di tutto per renderla una bambina felice, lui che, quando lei piccolina gli chiese di baciarla come baciava la mamma, le aveva regalato quel minuto contatto, lui che non dava troppa importanza alla balbuzie, per non farla sentire diversa e incompleta, proprio lui, padre modello attento alla costruzione di un idillio, subirà una figlia terrorista che piazza bombe innalzando le fondamenta per l’edificio della contro-pastorale in cui il padre non ha mai abitato.
Andy Mesnikoff lo aveva capito:
Any biography is chance, and, beginning at conception, chance- the tyranny of contingency- is everything. Chance is what I believed Mr.Cantor meant when he was decrying what he called God.
 La vita è caso. Vale a dire, non senso. Tanto vale accettarlo, secondo quanto ha fatto Mesnikoff. E continuare i nostri tragitti, le nostre parole crociate, le nostre brevi telefonate: pena, una colpa non commessa. Nella follia di un uomo che mette in forma persino il caso vestendolo di responsabilità.
La vita è caso. Vale a dire, non senso. Tanto vale accettarlo, secondo quanto ha fatto Mesnikoff. E continuare i nostri tragitti, le nostre parole crociate, le nostre brevi telefonate: pena, una colpa non commessa. Nella follia di un uomo che mette in forma persino il caso vestendolo di responsabilità.
Ritornano alla mente le parole di Karl Löwith sull’antinomia fato-libertà nella filosofia Nietzschiana. Di come l’uomo nuovo sia quello che fa della propria volontà il fato stesso. Che coniuga la scelta con il destino sopra di lui. Lasciando parlare Löwith: “Il fato impersonale s’individualizza nel proprio ´destino`, se si imbatte nella risoluta volontà individuale dell’uomo, giacché la volontà libera si attribuisce come destino il fato stesso” (K. Löwith, Nietzsche e l’eterno ritorno). Nel che, si nasconde un’azione eroica. Senza dubbio. Come anche Peter Sloterdijk sottolinea: “agli occhi degli antichi un mondo senza l’apparizione di eroi avrebbe significato il niente- lo stato di cose cui gli uomini sono esposti, senza alcuna resistenza, alla monarchia della natura. Il principio di questo universo senza eroi sarebbe stato: ogni cosa è provocata dalla physis, l’uomo non può nulla. L’eroe, al contrario,  fornisce la prova che anche per l’uomo è possibile agire e operare.” (P. Sloterdijk, Ira e Tempo)
fornisce la prova che anche per l’uomo è possibile agire e operare.” (P. Sloterdijk, Ira e Tempo)
Ma Bucky è un eroe moderno, più che epico. Un semi-eroe, potremmo dire, con spiragli che ricordano i grandi eroi omerici, come anche l’oltreuomo nietzschiano per l’aspetto citato, ma che in definitiva vengono traditi. È eroica la conversione del caso in propria colpa. La rinuncia a chinare il capo, ergendosi contro la tirannia dei fatti. Ma non la modalità della rinuncia; l’eroe non si lascia morire di vecchiaia ma anticipa la sua morte. L’eroe accelera il tempo e non lo attende. Non aspetta Achille, semi-dio, come nemmeno Ettore, completamente mortale. È un eroe incompleto, l’ex-professore di ginnastica. Eppure, forse, è proprio in questa incompletezza che s’annida la sua umanità.
Matteo Sarlo ha scritto per diverse riviste filosofiche, di critica cinematografica, viaggi, cronaca e narrativa urbana. Ha pubblicato Passagi sul vuoto, un saggio sul concetto di «vuoto» in filosofia





































































![POST-FOTOGRAFIE [PARTE 1]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/05/PostFotografie-620x300.jpg)





































![Black Mirror, o dell’uomo nella Postmodernità [PARTE 2]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/01/BM2-620x300.png)




![Black Mirror, o dell’uomo nella Postmodernità [PARTE 1]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/01/BM-620x300.png)
