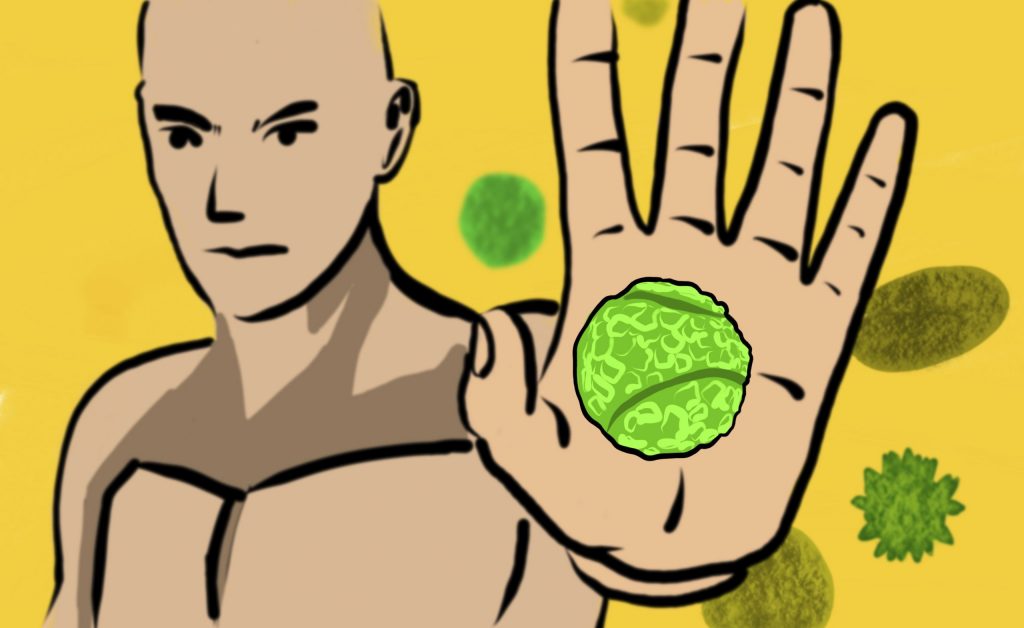
illustrazione di Matteo Sarlo
parole di Francesco Giordani
Il “fatto” del virus ha ben presto lasciato campo libero alle sue infinite interpretazioni. Si potrebbe sostenere che le interpretazioni – virologiche, epidemiologiche, mediche, statistiche, geo-politiche, economiche, religiose, etiche, letterarie – hanno interamente sostituito il fatto stesso della pandemia. È stato sufficiente seguire i dibattiti televisivi o leggere le sempre più articolate analisi di “esperti” di varia estrazione e orientamento, per capire che “di fatto” non è mai esistito né un solo Coronavirus né tantomeno una sola Pandemia ma, piuttosto, tante pandemie e tanti virus quante sono state le discipline, i saperi, i linguaggi specialistici convocati nel discorso pubblico per fornire una chiave interpretativa, una “narrazione” il più possibile coerente dell’evento a cui il mondo era ed è tuttora esposto. Abbiamo ben presto imparato che, pur messi di fronte a quello che ci appare come il medesimo fenomeno, Il Virologo non vede “la stessa cosa” dell’Economista, così come il Politico non può (né forse deve) vedere ciò che invece occupa la visione del Poeta, del Filosofo o dell’Imprenditore. Una rivincita tutt’altro che retorica di un principio d’indeterminazione epistemologica, per così dire, che deve farci tornare a riflettere, ancora una volta, sui limiti di quello che sappiamo (o crediamo di sapere) così come sulle procedure che empiricamente impieghiamo per “costruire” e articolare tale sapere in maniera “veridica”. Tali difficoltà discendono in maniera diretta dall’evento stesso del Coronavirus “in quanto Evento”, per così dire. Se infatti volessimo circoscrivere una minima “verità” della pandemia, al di là delle sue modalità effettive di propagazione e delle sue dimensioni più o meno misurabili, potremmo dire che essa è avvenuta. Non è un guadagno da poco: la Pandemia per COVID-19 è innanzitutto un Evento, qualcosa che è accaduto e che continua ad accadere. Meglio ancora: qualcosa che ci accade. La domanda slitta allora dalla Pandemia all’Evento stesso: che cos’è un Evento? Può venirci in soccorso Jacques Derrida quando spiega:
“L’evento è ciò che accade (arrive), imprevedibilmente, singolarmente. Non solo “ciò” che accade, ma “il chi” arriva (arrive), l’arrivante. (…). Perché un evento che si preveda è già accaduto, non è più un evento. Ciò che m’interessa nell’evento è la sua singolarità. Ciò ha luogo una volta, ogni volta una volta. Un evento è dunque unico e imprevedibile, vale a dire senza orizzonte. La morte è di conseguenza l’evento per eccellenza: imprevedibile nonostante sia prevista, essa arriva e non arriva affatto, poiché quando arriva, imprevedibile, non arriva più a nessuno.”
Lasciamo per un momento da parte la questione, assai complessa, di stabilire quanto l’imprevedibilità di una pandemia possa (o debba) essere oggi tecnicamente “prevedibile” e proviamo a concentrare la nostra attenzione sull’ultima parte della riflessione derridiana: ogni evento, in quanto evento che accade, viene “a noi” senza annunciarsi. Possiamo in qualche modo, come si usa dire, “aspettarcelo” ma, se di vero Evento si tratta, esso avverrà in una forma (e in un tempo e in un luogo) che non avevamo né avremmo potuto in alcun modo prevedere. Come la nostra Morte. Siamo molto vicini a uno degli aspetti decisivi della questione pandemica. Riportandoci di fronte ad un’incommensurabilità dell’Evento in quanto tale, questa Pandemia ci ha improvvisamente riconciliato con la possibilità sempre aperta della nostra morte. È talmente evidente, in questi giorni così drammatici, che dirlo pare quasi banale. Tuttavia, piuttosto che riattraversare una volta di più l’analitica esistenziale di un Heidegger, dovremmo iniziare a guardare all’Evento del Coronavirus da una prospettiva diversa, strettamente connessa con la nostra mortalità (o, per meglio dire, con il nostro essere-per-la-morte), ma rivolta verso una nuova forma di autenticità del nostro essere nel e con il Mondo. Come se proprio a partire dall’Evento della nostra Morte ci venisse restituita la possibilità di una nuova Vita. Ricominciare dalla Cosa Ci aiuta a comprendere questo passaggio un bel testo di Felice Cimatti, Cose. Per una Filosofia del Reale. Nei fatti, un piccolo trattato di ontologia a suo modo tanto atipico, per stile e ampiezza pluridisciplinare dei riferimenti, quanto stimolante. Ciò che più affascina è la tesi paradossale che ne anima per così dire il cuore argomentativo: gli umani possono diventare cose? Possono cioè esperire e “vivere” il mondo come le altre cose (pietre, alberi, fiumi, animali, un virus) lo vivono e lo esperiscono? Non sfuggirà la paradossalità di una simile domanda. Le cose tendono infatti a configurarsi, nell’esperienza ordinaria, da un lato come quanto di più distante (o di totalmente altro) rispetto alla nostra condizione di “umani” e, dall’altro, come ciò che a ci si presenta sempre disponibile nella forma di “oggetto” d’uso. Uso pratico, ovviamente, ma anche linguistico, simbolico e conoscitivo: le cose obbediscono al nostro “comando” soggettivo, rispondono alle nostre parole, ai nostri concetti, si mettono al “servizio” delle nostre percezioni e dei nostri desideri. Eppure non possiamo dimenticare che anche ciò che chiamiamo “cosa” ha una vita del tutto simile e indipendente dalla nostra. Non è un caso allora che la riflessione di Cimatti passi per una ridefinizione “allargata” del concetto di vita. La vita non può essere considerata una prerogativa esclusiva dell’“animale” umano, ovvero l’Homo Sapiens. Semmai, è vero il contrario, come ben mostrano molti esempi scientifici, ma anche letterari. Ecco come Primo Levi racconta la “storia” di un atomo di carbonio.
“Fu colto dal vento, abbattuto al suolo, sollevato a dieci chilometri. Fu respirato da un falco, discese nei suoi polmoni precipitosi, ma non penetrò nel suo sangue ricco, e fu espulso. Si sciolse per tre volte nell’acqua del mare, una volta nell’acqua di un torrente in cascata, e ancora fu espulso. Viaggiò col vento per otto anni, ora alto, ora basso, sul mare e fra le nubi, sopra foreste, deserti e smisurate distese di ghiaccio; poi incappò nella cattura e nell’avventura organica. (…) È di nuovo tra noi, in un bicchiere di latte. È inserito in una lunga catena, molto complessa, tuttavia tale che quasi tutti i suoi anelli sono accetti al corpo umano. Viene ingoiato: e poiché ogni struttura vivente alberga una selvaggia diffidenza verso ogni apporto di altro materiale di origine vivente, la catena viene meticolosamente frantumata, e i frantumi, uno per uno, accettati o respinti. Uno, quello che ci sta a cuore, varca la soglia intestinale ed entra nel torrente sanguigno: migra, bussa alla porta di una cellula nervosa, entra e soppianta un altro carbonio che ne faceva parte. Questa cellula appartiene a un cervello, e questo è il mio cervello, di me che scrivo, e la cellula in questione, ed in essa l’atomo in questione, è addetta al mio scrivere, in un gigantesco minuscolo gioco che nessuno ha ancora descritto. È quella che in questo istante, fuori da un labirintico intreccio di sì e di no, fa sì che la mia mano corra in un certo cammino sulla carta, la segni di queste volute che sono segni; un doppio scatto, in su e in giù, fra due livelli d’energia guida questa mia mano ad imprimere sulla carta questo punto: questo.”
Quanto si offre al nostro sguardo umano come apparentemente inanimato, immutabile, fermo, una “cosa” appunto, vive in realtà̀ un’esistenza pressoché́ infinita, un “romanzo” di forme chimico-biologiche in strettissima correlazione con il nostro corpo vivente (fatto anche di atomi di carbonio) e che anzi, in virtù di tale correlazione, ne costituisce la possibilità stessa di vita. Risuona in queste parole l’eco della scoperta fondamentale operata da Antoine Roquentin ne La Nausea, da leggere, al di là delle interpretazioni esistenzialistiche, anche come un manifesto di ontologia militante, un atto quasi politico di fedeltà alla vita delle cose:
“È cominciato da quel famoso giorno in cui volevo giuocare a far rimbalzare i ciottoli sul mare. Stavo per lanciare quel sassolino, l’ho guardato, ed è allora che è incominciato: ho sentito che esisteva.”
La Pandemia, sospendendo per un attimo lungo tre mesi il nostro primato ontologico, ci ha fatto ritornare “dentro” un mondo nel quale, come scrive Cimatti, la nostra vita è “una pertubazione temporanea della cosa”, catturata in una naturale pulsione di ritorno verso l’inorganico. Ai margini estremi di quell’era che da tempo abbiamo imparato a chiamare Antropocene, l’Uomo Postpandemico può dunque rifondare la propria origine e la propria destinazione, riscoprendosi parte del mondo, cosa fra le cose o, se si preferisce, Natura. Il Coronavirus ci ha infatti ricordato di essere, anche noi uomini, cose di questo mondo che, proprio in quanto cose, vivono all’interno di una Natura. Come direbbe Deleuze, siamo una “piega” di qualcosa di infinito e continuo, e una “piega dura il tempo che dura, poi la piega si allenterà, e più o meno lentamente si spegnerà, cioè si perderà”. Accogliere questa rivelazione silenziosa, significa certamente portare a compimento un esercizio collettivo di “riduzione trascendentale” di tutte le categorie dell’umano, ri-abbracciando l’”umile verità” di un qui e ora che tuttavia non ci condanna all’indifferenza impassibile quanto piuttosto ad una nuova e più vera forma di felicità, permeata di… “cinismo”. Una nuova vita da cani Il Cinismo è stata una “scuola” filosofica del mondo antico tanto celebre, quanto spesso equivocata che significativamente ha impegnato Foucault nel suo ultimo corso al College De France del 1984 dedicato alla “parresia” ovvero, alla lettera, al “diritto di dire il vero”. Secondo Foucault, “il dir-il-vero del cinico assume, in modo privilegiato, la forma di vita come testimonianza della verità”. La vita del cinico è la vera vita nel senso che è proprio una vita, osserva di riflesso Cimatti, “senza però smettere di essere una vita umana. (…) Il cinico non è un cane, ma non è nemmeno un uomo; è un cane che parla. È un cane, perché la sua è una vita affatto immanente, come appunto quella animale; è un uomo, perché parla come parlano gli esseri umani”. Possiamo dunque riconoscere che sì, l’Evento della Pandemia, esponendoci alla fine sempre possibile e mai prevedibile della nostra Morte che viene, ci ha reso più “cinici” di prima, più animali. Tuttavia. all’opposto, possiamo anche affermare che la Pandemia ci ha reso proprio per questo più vivi e dunque più veri, fedeli ad una “vita sovrana” autentica e, forse, felice.
“Il cinico non desidera infatti il cibo; ha fame. Non desidera una casa; ha freddo. (…) La povertà cinica è la stessa povertà di una lucertola o di un girasole. La vita cinica è la vita animale, non come allegoria o condanna, è la vita del mondo che è la vita animale, la vita vegetale, la vita minerale.”
Per questo Foucault può dire che “la vera vita sarà la vita di verità, che manifesta la verità, che pratica la verità nel rapporto con sé e con gli altri. In tal modo, questa vita di veridizione ha per obiettivo la trasformazione del genere umano e del mondo”. Intravediamo, alle soglie di questa trasformazione meta-antropologica che il Coronavirus potrà innescare (o forse ha già innescato) nel cuore stesso dell’umano, la possibilità di un “cambiamento d’aspetto” che Wittgenstein associava ad una “nuova visione” del mondo, capace di ribaltarne completamente il senso. Il cambiamento d’aspetto che è in gioco in questo momento della storia umana è però del tutto peculiare. Forse senza precedenti. Esso non ci invita semplicemente a guardare in modo nuovo il mondo, quanto piuttosto a vedere che un mondo esiste: “c’è” anziché non esserci, nella forma di una totalità vivente di cose della quale noi stessi siamo parte non discernibile, dunque infinita. Preso atto di questo “stato di cose” diventiamo noi stessi “atto”, processo vivente non più separato dal mondo. Si tratta di un tornare a casa, o “in famiglia”, di un sentirsi di nuovo al sicuro dentro il “miracolo del mondo”, come lo stesso Wittgenstein ha provato a descrivere nella sua Conferenza sull’Etica, con parole quasi da poeta o da mistico.
“Dire «Mi meraviglio di questo e di quest’altro», ha senso solo se posso immaginarmi che le cose non stiano così. In questo senso, ci si può meravigliare, diciamo, per l’esistenza di una casa, vedendola, non avendola visitata da molto tempo e avendo immaginato che l’avessero demolita nel frattempo. Ma non ha senso dire che mi meraviglio per l’esistenza del mondo poiché non posso immaginarlo non esistente. Posso certo meravigliarmi che il mondo attorno a me sia così. Se, per esempio, avessi una tale esperienza mentre guardo il cielo azzurro, potrei meravigliarmi del suo essere azzurro, invece che coperto di nubi. Ma non è questo che voglio dire. Mi sto meravigliando del cielo, comunque esso sia.”
Ecco, se alla “fine” di questa Pandemia avremo la forza e il coraggio di recuperare la capacità di vedere il mondo come tutte le cose -cani, nuvole, fili d’erba, punte di spillo, girasoli, fiamme, lucertole- lo “vedono” da sempre, forse, nel miracolo di una visione liberata dall’idea di sé stessa, “non avremo più bisogno di niente” e coincideremo autenticamente con il mondo. Proprio come un cane, o come un vero cinico, testimonieremo una fedeltà senza desideri al nostro destino di cosa vivente, collocata non “al centro” ma “dentro” il respiro del mondo. Torneremo a casa e non avremo più nulla da temere. Come canta il grande Milo De Angelis:
In noi giungerà l’universo
quel silenzio frontale dove eravamo
già stati.



































































![POST-FOTOGRAFIE [PARTE 1]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/05/PostFotografie-620x300.jpg)





































![Black Mirror, o dell’uomo nella Postmodernità [PARTE 2]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/01/BM2-620x300.png)




![Black Mirror, o dell’uomo nella Postmodernità [PARTE 1]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/01/BM-620x300.png)
