illustrazione di Michel Chabaneau parole di Matteo Sarlo
intensità

ABOUT TWO AND A HALF MONTHS after the well-trained divisions of north Korea, armed by the Soviets and Chinese Communists, crossed the 38th parallel into South Korea on June 25, 1950, and the agonies of the Korean War began, I entered Robert Treat, a small college in downtown Newark named for the city’s seventeenth-century founder.
Nell’impaginazione della Jonathan Cape (2008), il primo punto arriva dopo otto righe. Ora, non è che si possa sostenere che la scrittura di Roth sia iberica. Ma otto righe sono otto righe. Questo vuol dire che Philip Roth è uno scrittore da merlettaia? Considerando che una delle più ricorrenti critiche – non esattamente di critica letteraria ma tant’è, c’è e ce la teniamo – è stata quella di essere un sessista erotomane che pensa solo a se stesso, direi che no, il punto di Philip Roth non è quello di fare i ghirigori – che poi la storia abbia dimostrato che puoi essere uno scrittore pazzesco ed essere, che so, stronzo o nazista, è un altro discorso. Allora, se non è perché gli piace fare i coriandoli, perché Roth decide di iniziare Indignation andando così lungo? Riprendiamo l’incipit e dividiamolo a metà:
ABOUT TWO AND A HALF MONTHS after the well-trained divisions of north Korea, armed by the Soviets and Chinese Communists, crossed the 38th parallel into South Korea on June 25, 1950, and the agonies of the Korean War began,
soggetto + verbo + complemento (ancora più idealmente il soggetto è sempre uno: io.)
Perché Roth decide di poggiare tutto su un avverbio così insignificante come about? Per due motivi:- sa benissimo che scrivere come prima parola about significa farti restare con il fiato in gola finché non trovi la principale, quella che inizia con Io e che è pulita pulita soggetto + verbo +complemento.
- sta facendo una promessa al lettore: in questo romanzo i soggetti del racconto saranno almeno due, la guerra di Corea, la guerra con la “s” minuscola e, per via allegorica, il destino, il fato, l’ananke.
più materia, più oltrepassamento della materia.
Già, perché da about a began non c’è una metafora. Ogni parola è referenziale, cosa che apparenta il suo linguaggio a quello di Franz Kafka, a cui ha dedicato «Ho sempre voluto che ammiraste il mio digiuno» ovvero, guardando Kafka, comparso sull’American Review nel 1973 e, due anni dopo, in Reading Myself and Others. E quindi di certo la cosa che sta facendo Roth è darti informazioni ma mentre ti dà le informazioni, mentre ti dice dove siamo, quando, che cosa succede, Roth ti sta dando dicendo a quale passo camminare. È come un metronomo. Ti dice come devi arrivare all’informazione cruciale, che è la seconda parte, questa:I entered Robert Treat, a small college in downtown Newark named for the city’s seventeenth-century founder.

It was in the summer of 1998 that my neighbor Coleman Silk- who, before retiring two years earlier, had been a classics professor at nearby Athena College for some twenty-odd years as well as serving for sixteen more as the dean of faculty- confided to me that, at the age of seventy-one, he was having an affair with a thirty-four-year-old cleaning woman who worked down at the college
Ora ridividiamolo a metà:It was in the summer of 1998 that my neighbor Coleman Silk – who, before retiring two years earlier, had been a classics professor at nearby Athena College for some twenty-odd years as well as serving for sixteen more as the dean of faculty – confided to me that, at the age of seventy-one,
La stessa cosa. La frase semplice, quella soggetto + verbo + complemento, la principale insomma, quella che ti fa recuperare il fiato, arriva dopo molto tempo che Roth gira e rigira. Prima c’è l’estate del 1998, poi c’è una digressione su Coleman che ti dice quanto sia divenuto un’autorità all’Athena College, poi ti dice quanto tempo ha esercitato lì, poi ti dice quando ha confidato ciò che Nathan Zuckerman sta per rivelare, e poi arriva la frase che aspetti dall’inizio, quella che ti fa sedere sul divano per un secondo:he was having an affair with a thirty-four-year-old cleaning woman who worked down at the college
Questo modo di periodare non è una forma estrinseca alla “storia”. Non è una questione di “stile” ma di precisione per la lingua, e cioè tutto ciò che è uno scrittore. E probabilmente Roth lo è diventato per la prima volta, uno scrittore, quando, all’età di undici anni, aveva deciso di scrivere tutta una serie di avventure di mare sotto lo pseudonimo di Eric Duncan perché non resisteva «alle “c” dure». Sia chiaro, non era uno scrittore in quel momento perché si era messo in testa di raccontare storie di mare, una cosa che l’ottanta per cento di ragazzini pensa di fare durante l’infanzia, ma per la storia delle c dure. E insieme il tono quasi da aedo, da racconto orale che ha tutta la sua letteratura dove esplode la sua antica passione per i notiziari e i radiogrammi di Norman Corwin. Aveva 12 anni quando non si perdeva una puntata di On a Note of Triumph, «una delle esperienze più elettrizzanti della mia infanzia».durata
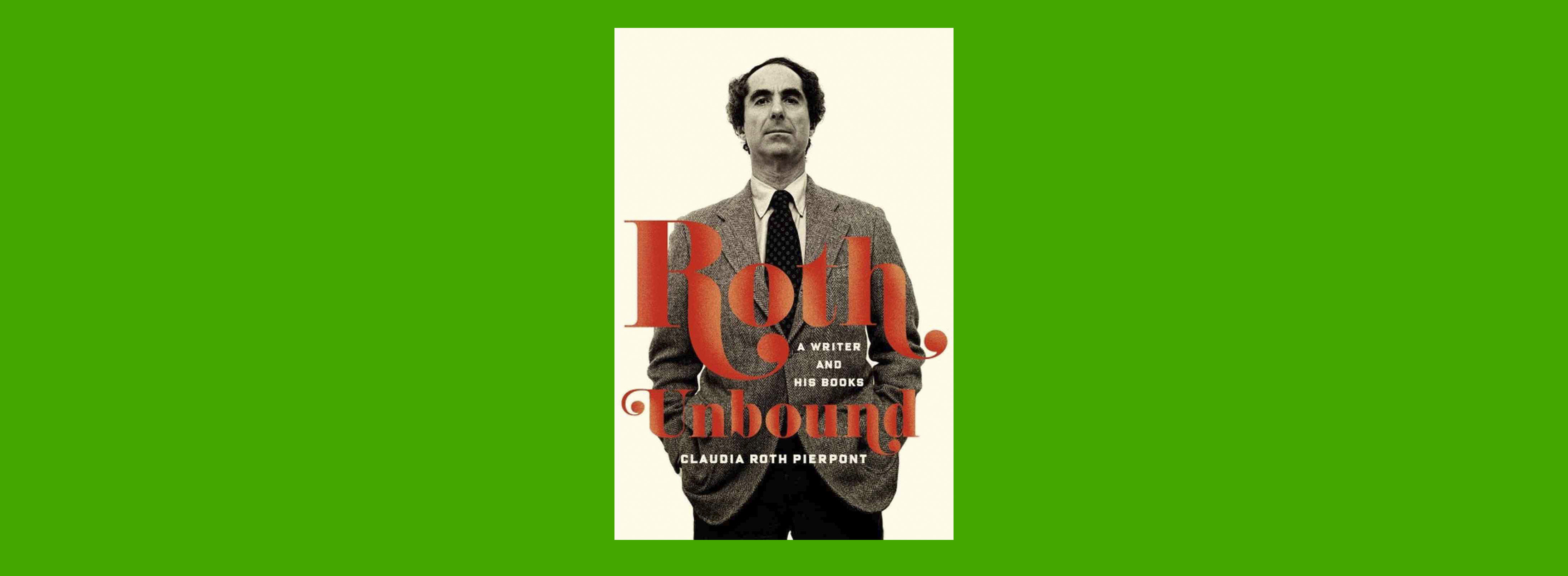
frequenza

being game in the face of the worst. Not courageous. Not heroic. Just game
Il being-game, qualcosa che potremmo tradurre come l’essere disposti a giocarsela. L’essere-gioco. L’esserci in quanto gioco. Dato che le nostre vite sono nude, prive di grazia e redenzione, allora non fare l’eroe, non perdere tempo a fare il cuor di leone, ma impara a stare semplicemente al gioco. Intensità, durata, frequenza: la grandezza di un uomo. Philip Roth.Matteo Sarlo ha scritto per diverse riviste filosofiche, di critica cinematografica, viaggi, cronaca e narrativa urbana. Nel 2018 ha pubblicato Pro und Contra. Anders e Kafka.




































































![POST-FOTOGRAFIE [PARTE 1]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/05/PostFotografie-620x300.jpg)





































![Black Mirror, o dell’uomo nella Postmodernità [PARTE 2]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/01/BM2-620x300.png)




![Black Mirror, o dell’uomo nella Postmodernità [PARTE 1]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/01/BM-620x300.png)
